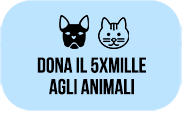a cura della Dott.ssa Francesca Lavarini, biologa specializzata in Antropologia ed Etologia
La ricerca human-based (vale a dire incentrata sull’uomo) ha un approccio che utilizza metodologie e tecnologie innovative per studiare le malattie umane e sviluppare farmaci, puntando a ottenere risultati più precisi e rilevanti per l’uomo rispetto ai modelli animali.
Questo tipo di ricerca si basa sulla biologia umana e cerca di riprodurre condizioni fisiologiche umane per una maggiore comprensione delle malattie e per lo sviluppo di trattamenti più efficaci.
La ricerca human-based si distingue per:
 Metodologie innovative: Utilizza nuovi approcci metodologici (NAMs), come modelli microfisiologici, organoidi e organ-on-chip, che riproducono in laboratorio l’ambiente di un organo o di un sistema di organi umani.
Metodologie innovative: Utilizza nuovi approcci metodologici (NAMs), come modelli microfisiologici, organoidi e organ-on-chip, che riproducono in laboratorio l’ambiente di un organo o di un sistema di organi umani.
Focus sulla biologia umana: Si concentra sulla biologia umana, le malattie umane e le risposte dell’organismo umano alle sostanze e ai trattamenti.
Precisa previsione delle risposte: I metodi human-based hanno dimostrato di essere più accurati nella previsione delle risposte umane rispetto ai modelli animali.
Superamento della sperimentazione animale: La ricerca human-based può contribuire a ridurre la necessità di sperimentazione animale nella ricerca biomedica, sostituendo i modelli animali con metodi più precisi e rilevanti per l’uomo.
Adattamento della ricerca a nuove tecnologie: La ricerca human-based abbraccia le nuove tecnologie come la genomica, la proteomica e l’imaging per studiare la biologia umana in profondità.
Integrazione di dati: La ricerca human-based integra dati provenienti da diversi settori come la biologia, la chimica, la fisica e l’ingegneria per una comprensione più completa della biologia umana.
Alcuni esempi di ricerca human-based sono:
- Studio dell’interazione tra dieta e microbiota intestinale e il loro impatto sulla salute cerebrale, utilizzando modelli di organ-on-chip che simula il sistema digestivo e il cervello.
- Utilizzo di modelli microfisiologici per studiare l’assorbimento dei farmaci nell’intestino umano.
- Studi sulla progressione della malattia di Alzheimer utilizzando modelli umani in vitro.
Organoidi immunitari umani per lo studio del cancro
 Un team di ricercatori del Georgia Institute of Technology ha sviluppato in laboratorio modelli in miniatura del sistema immunitario umano, per comprendere meglio perché alcuni pazienti oncologici facciano fatica a combattere le infezioni.
Un team di ricercatori del Georgia Institute of Technology ha sviluppato in laboratorio modelli in miniatura del sistema immunitario umano, per comprendere meglio perché alcuni pazienti oncologici facciano fatica a combattere le infezioni.
Questi modelli, basati su organoidi (repliche in miniatura di organi e tessuti umani e derivanti da cellule staminali) e chiamati organoidi immunitari umani, replicano l’ambiente in cui le cellule immunitarie imparano a riconoscere e attaccare gli agenti nocivi.
Questi organoidi rappresentano uno strumento per studiare il funzionamento del sistema immunitario in condizioni oncologiche. Per la prima volta, si possono ricreare e mantenere complessi processi immunologici in un gel sintetico usando sangue umano e monitorare efficacemente le risposte delle cellule B.
Il team ha progettato organoidi che imitano il tessuto delle tonsille e dei linfonodi umani, fondamentali per studiare le risposte immunitarie. Gli organoidi permettono alle cellule immunitarie, prelevate da sangue umano e tonsille, di maturare e produrre anticorpi in un ambiente controllato. Questo processo simula quanto avviene nel corpo umano e consente di studiare la risposta immunitaria in dettaglio.
Testando cellule provenienti da donatori sani e da pazienti con linfoma, i ricercatori hanno scoperto che le cellule immunitarie di chi ha sofferto di linfoma, trattati con specifiche immunoterapie, non si organizzano in “zone” funzionali, come avviene in una risposta immunitaria normale.
Questa mancanza di organizzazione potrebbe spiegare alcune delle difficoltà che ex malati di cancro affrontano nel combattere le infezioni. I risultati sono stati poi pubblicati sulla rivista scientifica Nature Materials.
Il Microbioma umano
 È l’insieme della popolazione di miceti (funghi), virus e batteri che vivono in simbiosi con il corpo umano. Presenti in diverse parti anatomiche: colon, retto, vagina, pelle, parete gastrica, bocca, gola, cervello.
È l’insieme della popolazione di miceti (funghi), virus e batteri che vivono in simbiosi con il corpo umano. Presenti in diverse parti anatomiche: colon, retto, vagina, pelle, parete gastrica, bocca, gola, cervello.
La loro popolazione basale (che varia da ceppo a ceppo) comporta lo stato di salute del nostro corpo, garantendo un sistema immunitario sano.
Studi su microbioma umano di pazienti affetti da diverse patologie (tra cui l’infertilità inclusa) stanno ampiamente dimostrando la forte dipendenza dal microbioma, inteso come variazione dalla condizione fisiologica.
Ciò significa che la variazione in eccesso o in difetto della popolazione fisiologica porta alla comparsa nell’uomo di molte patologie: per esempio, le donne infertili hanno un microbioma alterato in sede vaginale ed intestinale.
Negli ultimi anni, l’asse intestino-cervello si è affermato come uno dei campi più allettanti nella ricerca biomedica. Questo sistema di comunicazione, che connette il tratto gastrointestinale al sistema nervoso centrale, svolge un ruolo cruciale nella regolazione dell’umore, del comportamento, della memoria, del metabolismo e della risposta immunitaria.
Oggi sappiamo che la dieta, attraverso l’interazione con il microbiota intestinale, può influenzare in modo sostanziale il nostro cervello.
Organoidi intestinali, ad esempio, hanno mostrato come i batteri probiotici possano stimolare la produzione di ossitocina, un ormone solitamente associato al cervello, ma che viene prodotto anche a livello intestinale in risposta a stimoli microbici. Questo apre prospettive del tutto nuove per comprendere come il microbiota influenzi emozioni e comportamento.
Oltre agli organoidi, i ricercatori stanno adottando sempre di più sistemi di organ-on-chip, piattaforme microfluidiche che ricreano l’ambiente fisiologico di un organo umano o di un sistema di organi.
In questi chip, cellule intestinali, epatiche o cerebrali vengono coltivate in camere interconnesse, con un flusso continuo di nutrienti e metaboliti, simulando la circolazione sanguigna.
In questo modo è possibile osservare in tempo reale come una sostanza ingerita venga trasformata dal microbiota, metabolizzata dal fegato e poi arrivi al cervello.
In uno di questi modelli multi-organo, ricercatori hanno collegato intestino, fegato e cervello per studiare l’effetto del microbiota TMAO.
Hanno osservato che questo composto non solo attraversa la barriera emato-encefalica, ma altera anche l’attività dei neuroni, suggerendo una possibile connessione tra dieta ricca di grassi animali e sviluppo di patologie neurologiche.
Causa della progressione dell’Alzheimer
Per la prima volta, hanno utilizzato dati umani (campioni del cervello post-mortem di pazienti malati di Alzheimer) per quantificare la velocità dei processi che portano alla malattia ed hanno scoperto che si sviluppa in modo molto diverso rispetto a ciò che si credeva.
Un team internazionale guidato dall’Università di Cambridge ha scoperto che, invece di partire da un singolo punto del cervello per poi avere una reazione a catena che porta alla morte delle cellule cerebrali, l’Alzheimer raggiunge precocemente diverse regioni del cervello.
I ricercatori hanno tracciato l’irroramento della proteina tau, una delle proteine “chiave” della malattia. La tau si accumula insieme ad un’altra proteina formando grovigli e placche che causano la morte delle cellule cerebrali e il deterioramento del cervello. Da qui si passa alla perdita di memoria, cambiamenti di personalità e difficoltà a svolgere le funzioni quotidiane.
Usando cinque diversi campioni di dati ed applicando lo stesso modello matematico, i ricercatori hanno osservato che il meccanismo che controlla il tasso della progressione della malattia è la replicazione degli aggregati nelle singole regioni del cervello e non la diffusione degli aggregati da una regione ad un’altra.
Lo sviluppo della malattia suggerisce nuovi modi per sviluppare futuri trattamenti.
Conclusione
Queste sono solo alcune delle nuove scoperte avvenute senza l’uso di animali il quale, al contrario, porta spesso a dati fuorvianti.
Basti pensare che la stragrande maggioranza dei farmaci (il 90%) che hanno superato con successo i test preclinici fallisce nelle fasi cliniche.
La percentuale di fallimenti è dell’85% nelle prime fasi cliniche, e solo la metà di quelli che arrivano alla fase III vengono approvati per l’uso clinico.
La maggior parte dei fallimenti si verifica nei test dei farmaci per il cancro, principalmente a causa della mancanza di efficacia clinica (40-50%) o per tossicità (30%).
24 APRILE
Genova – Giornata degli animali da laboratorio